Quando il refuso tradisce il “copia-incolla”
Una casa editrice aveva richiesto ad una traduttrice la traduzione di un racconto croato del Diciottesimo secolo; tuttavia l’editore, ad opera consegnata, aveva deciso di non procedere più ad alcuna pubblicazione a causa degli eccessivi costi di stampa. A distanza di un anno il testo viene però pubblicato, con una nuova traduzione, a firma di un altro interprete.
La prima traduttrice, nel confrontare la propria versione a quella andata in stampa, si accorge però che quel lavoro non è altro che una copia della sua. Di qui la querela, e il processo penale, arrivato fino alla Cassazione, e la condanna del secondo traduttore per “plagio”.
I giudici hanno infatti accertato che la traduzione dell’imputato era perfettamente sovrapponibile, con un’identità pari quasi al 90%, a quella della prima traduttrice: interi periodi, nell’una e nell’altra versione, erano identici, anche in quei passaggi, come i dialoghi, in cui maggiore avrebbe dovuto essere l’apporto soggettivo dell’interprete; le differenze, al contrario, tra i testi erano davvero modeste, come la modifica di una singola parola, l’inserimento di qualche articolo, l’inversione dei termini nella frase.
Davvero poco per parlare della traduzione mandata in stampa come di un lavoro autentico e creativo.
Ma qual è stato l’elemento che ha fatto definitivamente ritenere di essere in presenza di un fedelissimo copia-incolla di un lavoro altrui? La riproduzione, nel testo del ricorrente, degli stessi errori grammaticali, o di battitura, presenti nella prima traduzione: refusi evidentissimi, come una doppia mancante, una lettera in più o in meno, un nome proprio scritto in minuscolo, la spaziatura delle parole non corretta, che – e qui è il punto fondamentale – comparivano esattamente nello stesso punto in entrambi i testi.
E se tutto ciò fosse stato solo frutto di un caso “sciagurato”?
Considerando che il testo era composto da decine di pagine, la probabilità che, su migliaia di parole, autori diversi potessero compiere errori identici, oltretutto replicati qua e là, e che avessero potuto farlo nelle stesse parti della traduzione, era praticamente nulla.
C’è di più: il giudice ha anche ritenuto che l’autore della traduzione poi andata in stampa non soltanto si è limitato ad introdurre varianti lessicali di dettaglio minimo, usurpando completamente un’opera non sua, ma, proprio attraverso quelle lievi differenze, ha provato a mascherare la contraffazione. Tra l’altro, questi, per il puro vanto di vedere un’opera uscire a suo nome, aveva anche accettato di “lavorare” gratuitamente.
Insomma, non c’è davvero pace per i “copioni”… meno che mai per quelli maldestri!


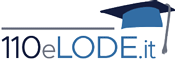
 HELP Tesi
HELP Tesi